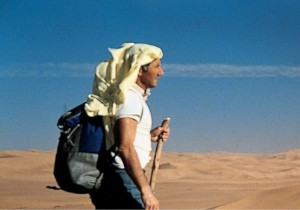Nel 2025 tra giugno e luglio in montagna ci sono stati 83 morti e quasi tre decessi al giorno, e ad agosto – secondo quanto riportava l’Ansa – la situazione non è mutata, con la prospettiva di circa 100 morti in incidenti in montagna, dagli alpinisti in cordata a quota 4mila agli escursionisti a passeggio sui sentieri. Secondo il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino (CNSAS) – che fornirà i dati complessivi degli interventi e dei decessi al termine della stagione – il 44% riguarda escursionisti colpiti da malori o rimasti coinvolti in cadute, mentre il 56% è legato a tutte le altre attività outdoor in montagna.
Il 2025 potrebbe essere un anno record per incidenti e morti tra i ciclisti in strada
Sulle strade la situazione non è diversa. Secondo il bilancio aggiornato dell’Osservatorio ciclisti Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, il 2025 potrebbe essere un anno record per incidenti e morti tra i ciclisti in strada, e comunque ad agosto eravamo già al massimo degli ultimi 8 anni: 155 morti nei primi otto mesi dell’anno, 140 uomini e 15 donne di cui 74 ‘over 65’, e 15 decessi provocati da pirati della strada (in tutto il 2024 secondo i dati Istat, i ciclisti morti sono stati 185). Per la precisione i morti sono stati 12 a gennaio, 15 a febbraio, 14 a marzo, 19 ad aprile, 25 a maggio (record negativo degli ultimi anni), 21 a giugno, 19 a luglio. Per quanto riguarda le regioni, in testa c’è la Lombardia con 38 morti, poi Emilia Romagna con 25 e Veneto con 21. Rispetto al periodo gennaio-agosto 2024 le vittime sono aumentate del 14 per cento (136).
Si potrebbe banalmente dire che non c’è mai stata così tanta gente in giro, in montagna e in bicicletta, sulle strade e fuori strada. Ed è sicuramente vero che da dopo la pandemia c’è stato un vero e proprio boom della montagna, e più in generale dell’outdoor (basti ricordare i numeri monstre di vendite con i vari bonus bici). Ma non è tutto e solo nella quantità e in una relazione di linearità numerica tra numero di praticanti e numero di incidenti. C’è qualcosa di più profondo, tra l’Effetto Peltzman e alcuni bias cognitivi correlati alla fiducia nella tecnica, che ci espone a un falso senso di sicurezza anche quando ci dedichiamo alle nostre amate attività outdoor.
L’Effetto Peltzman e il falso senso di sicurezza
L’Effetto Peltzman nasce in ambito automotive, quando Sam Peltzman, professore di economia alla University of Chicago Booth School of Business, pubblicò sul Journal of Political Economy l’articolo The Effects of Automobile Safety Regulation in cui si notava come l’introduzione di una serie di regole per il settore automobilistico volte ad aumentare la sicurezza delle automobili e dei loro passeggeri, prevalentemente grazie all’utilizzo di dispositivi tecnologici che nello stesso tempo aumentavano notevolmente il costo del veicolo, non aveva fatto diminuire i decessi per incidenti stradali. Secondo Peltzman, i regolamenti che intendono aumentare la sicurezza sono nel migliore dei casi inutili, mentre nel peggiore addirittura controproducenti.

Se n’era accorto già più di 10 anni fa Outside che scriveva che i dispositivi di sicurezza inducono a comportamenti “più spericolati” (o quantomeno meno guardinghi). E snocciolava anche alcuni interessanti dati che sicuramente oggi non sono migliorati: 83% di incidenti da valanga che coinvolgono sciatori e snowboarder addestrati al soccorso in valanga, dovuti a decisioni sbagliate anziché alle condizioni del terreno o del manto nevoso; 7 cm in meno di distanza che un automobilista mantiene da un ciclista che indossa il casco; nessuna diminuzione del rischio di lesione del legamento crociato anteriore per chi pratica attività ricreative indossando una ginocchiera; 50% di probabilità di essere uccisi o feriti da un grizzly mentre ci si difende con una pistola; 0 vantaggio protettivo di un casco da bicicletta costoso rispetto a uno economico; 0 diminuzione degli incidenti sciistici mortali annuali nelle località turistiche dall’adozione diffusa dei caschi di sicurezza.
La sicurezza è diventata una potente leva di marketing e comunicazione
Oggi la disponibilità di “dispositivi di sicurezza” (o presunti tali) è letteralmente esplosa: App di navigazione outdoor, che ci fanno pensare che ci possano guidare esattamente come quelle che utilizziamo nel traffico: radar di segnalazione delle auto per quando siamo in bicicletta; caschi di ogni tipo e per ogni segmento di attività; previsioni meteo; GPS satellitari; smartphone; App e dispositivi che inviano subito la richiesta di segnale di soccorso e avvisano i propri cari; e chi più ne ha più ne metta. La sicurezza è quindi diventata una potente leva di marketing e comunicazione di qualunque prodotto outdoor, dalle scarpe (e perfino calze) ai vari dispositivi “antivalanga”.
Ciò che non è chiaramente acquisito, quantomeno dall’utente medio – ma a giudicare dalle cronache anche agli utenti esperti – è che laddove si introduce una protezione (obbligatoria) la percezione del rischio si abbassa, incentivando comportamenti che vanno nella direzione opposta agli effetti auspicati dalla norma di sicurezza stessa. È esattamente il motivo per cui “la Federazione Italiana Amici della Bicicletta (FIAB onlus), in accordo con tutte le associazioni europee per la promozione della bicicletta riunite sotto la sigla ECF, è favorevole all’uso del casco, ma esprime netta contrarietà a una norma che disponga l’obbligo generalizzato di indossarlo nell’utilizzo della bici anche per la mobilità quotidiana.”

Tutti noi guardiamo con sconforto ai ricorrenti video di gitanti in infradito o sneaker sul ghiacciaio del Monte Bianco, ma poi i “merenderos” in infradito o sneaker non rientrano praticamente mai nelle cronache e nelle statistiche degli incidenti in montagna (o in bici, o in acqua, se vogliamo parlare anche del numero elevato di affogamenti in acqua). Cioè non è solo perché – come dice il CNSAS – “le montagne italiane, da nord a sud, sono affollate da persone che non sono attrezzate per questo tipo di turismo. Una grande fetta lo fa solo per poter scattare una foto da postare sui social, senza avere le conoscenze tecniche – compresi gli itinerari idonei – o banalmente l’abbigliamento adatto. In molti indossano le scarpe sbagliate, scarpe da ginnastica che si usano in città, o affrontano i sentieri con magliette di cotone, non adatte. C’è una forma di incoscienza: chi sceglie di salire in pantaloncini, in alcuni casi senza portarsi dietro neanche l’acqua, mette a rischio la propria vita“. È anche perché ci facciamo blandire da un falso senso di sicurezza.
Il senso di sicurezza porta a un eccesso di fiducia
“Il senso di sicurezza è uno dei rischi più pericolosi che un cliente possa correre. Crea punti ciechi. Porta a un eccesso di fiducia. Ma soprattutto, ritarda l’adozione di misure significative fino a quando non si verifica una violazione. Quando le misure di protezione sono basate sull’apparenza o sulla convenienza, possono riuscire ad alleviare le ansie, ma falliscono quando vengono messe alla prova da una minaccia determinata. La vera sicurezza non è ciò che le persone vedono, ma ciò che i sistemi, il personale e i protocolli sono in grado di sopportare sotto pressione.” Sono parole di un’agenzia specializzata in servizi di sicurezza privata che sono perfette anche per il falso senso di sicurezza che ci porta a subire incidenti potenzialmente fatali durante le nostre amate attività outdoor.
C’è un interessante studio pubblicato su Frontiers in Psycology (From a false sense of safety to resilience under uncertainty) che ci può aiutare a capire questo meccanismo: “comprendere e agire in base al rischio è particolarmente difficile, e affrontare la complessità con conoscenze sviluppate per ambienti stabili può inavvertitamente creare un falso senso di sicurezza. Trascurare il potenziale di cambiamenti non lineari o eventi “black swan” – eventi altamente impattanti ma non comuni – può portare a un’ottimizzazione ingenua in condizioni di presunta stabilità, esponendo i sistemi a rischi estremi.”

Il tema del falso senso di sicurezza è collegato a quello psicologico della fiducia che riponiamo nei dispositivi di sicurezza. Secondo il sociologo e filosofo tedesco Niklas Luhmann “la fiducia ha come effetto la riduzione della complessità sociale, e quindi la semplificazione della vita attraverso l’assunzione di un rischio”. Di più: Luhmann definisce la fiducia come “un “investimento a rischio”, funzionale a connettere la limitata conoscenza e la parziale ignoranza delle riduzioni della complessità ambientale effettuate dai contesti comunicativi di cui, secondo la teoria dei sistemi, è formata la società complessa, estrapolando elementi informativi dall’evidenza disponibile. Il razionale dell’azione, basata sulla fiducia, consisterebbe in un “movimento verso l’indifferenza: introducendo la fiducia, alcune possibilità di sviluppo possono essere escluse dalla considerazione“. Ma la fiducia è proprio ciò che cercano di conquistare gli esperti di marketing per venderci i loro prodotti, dalle automobili agli occhiali per pedalare nel bosco.
Scambiamo lo sviluppo tecnico per progresso umano per la nostra sfida faustiana alla natura
Viviamo nell’era della tecnologia e sempre più scambiamo lo sviluppo tecnico per progresso umano, e la disponibilità tecnologia per evoluzione. Scriveva il filosofo e sociologo americano Lewis Mumford ne “Il mito della macchina” che “l’attuale eccessiva fiducia nella tecnica è dovuta a un’interpretazione radicalmente sbagliata dell’intera storia umana: se l’abilità tecnica bastasse da sola a identificare e a esprimere l’intelligenza, l’uomo sarebbe stato per molto tempo assai più indietro di altre specie” più ingegnose, come api, formiche o castori. E allora forse bisognerebbe riprendere qualche spunto da “L’uomo e la tecnica” di Oswald Spengler, a cominciare dall’idea che la massificazione e la deificazione della tecnica siano nient’altro che una sfida faustiana alla natura, destinata inevitabilmente al deperimento dell’uomo stesso.
Perché come teorizzava l’economista Frank H. Knight, è proprio quando ci troviamo in un ambito in cui regna l’incertezza che abbiamo la possibilità di imparare qualcosa. Per esempio a calcolare i rischi di fronte a una situazione potenzialmente pericolosa, e a fare le buone scelte che evitano le conseguenze negative.
LEGGI ANCHE
Cos’è il divertimento di Tipo 2 e perché dovresti scoprirlo
Forse il GPS spegne il nostro senso dell’avventura?
La natura è l’ultimo spazio di avventura che ci è rimasto
©RIPRODUZIONE RISERVATA